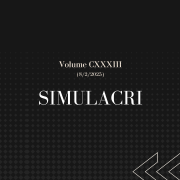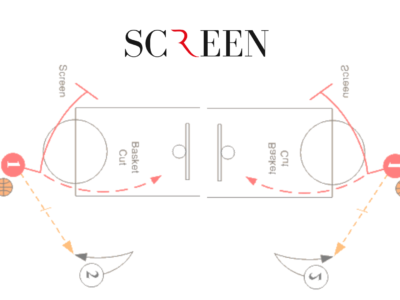di Guglielmo De Feis
L’applicazione pedissequa del protocollo VAR sta trascinando in una deriva “legalistica” ormai senza fine – e che pare perfino irreversibile – il calcio in generale e quello italiano in particolare. Nella patria culturale della frase “dove sta scritto che non posso fare ciò?” era inevitabile che la Serie A potesse aggiungere dei negativi tratti distintivi nazionali all’eccessivo e universale utilizzo della tecnologia. Infatti il sospetto che prima incombeva sull’arbitro si è semplicemente trasferito su chi adesso opera al VAR.
Fino al 2017 – ovvero l’anno di introduzione del Var – sembrava che il problema nell’amministrazione della giustizia calcistica fosse solo quello della precisa e tempestiva individuazione delle condotte scorrette o fallose. Si immaginava infatti, in maniera ottimistica, che un regolamento fondamentalmente semplice come quello del calcio (basato non dimentichiamolo su sole diciassette regole) non potesse produrre difficoltà nel momento in cui si fosse trattato di trovare la reale corrispondenza tra il fatto concreto e la regola generale ed astratta.
Abbiamo forse tutti addirittura pensato che il VAR potesse essere, almeno in ambito calcistico, la rappresentazione della giustizia personificata dalla donna bendata, con in mano una spada e una bilancia, della famosa opera di Pieter Bruegel il Vecchio.
Invece, ci siamo dovuti accorgere, un pezzo alla volta e con molte difficoltà, di quanto sia ampio il divario tra la neutralità idealizzata della legge e la sua realtà incarnata, tra la giurisprudenza astratta e l’evento sociale della giustizia. Più concretamente: quanto sia grande il divario tra individuare un contatto (tra i piedi di due giocatori o del pallone con un braccio) e lo stabilire se punire questo stesso contatto con un rigore o con un’espulsione.
D’altra parte l’immaginario giuridico calcistico italiano non è per nulla sofisticato e nemmeno si basa su un insieme di valori – etici, morali, filosofici, culturali e sportivi – condivisi. Per il tifoso italiano, la giustizia va amministrata con l’inflessibile spada quando rivolta verso la squadra avversaria e con la precisione e l’equità della bilancia quando riferita alla propria.
È possibile, anzi, che il tifoso italiano si spinga oltre e che all’equità (per la sua squadra) e all’inflessibilità (per quella avversaria) della giustizia bendata preferisca l’applicazione di una giustizia sommaria e basata sulle evidenze, a patto che sia la magnanimità di Re Salomone per la sua squadra e l’intransigenza di Traiano, per quella avversaria.
La giustizia di Salomone, nel celebre episodio delle due mamme che si contendono uno stesso bambino, enfatizza il ruolo della conoscenza del mondo e della saggezza da parte di colui che giudica quel determinato evento: perfetta per la propria squadra.
La giustizia di Traiano – in una meno conosciuta leggenda medievale, nella quale Traiano punisce un uomo colpevole dell’uccisione del figlio di una donna, sulla base della semplice accusa di quest’ultima – sottolinea l’urgenza morale di agire tempestivamente in nome dell’equità in difesa dei deboli con un’immediata assunzione di responsabilità da parte di colui che giudica: e questa è una forma di giustizia perfetta per la squadra avversaria.
Il problema peraltro diviene complesso nel momento in cui i casi giuridici da dirimere sono ripetuti con cadenza settimanale e diventa a quel punto inevitabile essere alternativamente colpiti sia dalla spada che dalla bilancia, dalla giustizia magnanima di Re Salomone e da quella sommaria di Traiano.
Sono tutti egualmente convinti di essere sempre vittime della spada e di Traiano – e se ne lamentano pubblicamente – mentre, guarda caso, tutti tacciono quando l’equità della bilancia e di Salomone li grazia.
Eppure un atteggiamento in apparenza tanto incoerente presenta delle valide motivazioni: chi si lamenta dell’inflessibilità della giustizia calcistica, sostenendo che non sia realmente giusta, è dalla parte della ragione.
È inspiegabile che in nome dell’oggettività – quella valutabile e misurabile dalla tecnologia – si sacrifichi qualunque valutazione sull’elemento soggettivo dell’intenzione di colui che commette l’azione fallosa. Se consideriamo che perfino per i gerarchi nazisti a Norimberga e per Eichmann a Gerusalemme, i giudici cercarono di comprendere le reali cognizioni soggettive di coloro i quali avevano agito, è paradossale che oggi su un campo di calcio si possa essere sanzionati con il massimo della pena (il rigore o l’espulsione) per un’azione che né si voleva realmente compiere e nemmeno si è commessa per una particolare responsabilità o colpa.
Nella Seconda Lettera ai Corinzi, San Paolo scrive: “la lettera uccide, ma lo Spirito dà la vita”. Nell’interpretazione tradizionale che per oltre milleduecento anni è stata data a questa frase, l’uso è strettamente teologico ed è un principio ermeneutico che distingue tra il senso letterale e quello spirituale delle Scritture.
Già durante il Medioevo, peraltro, la frase di San Paolo è stata adattata per spiegare la doverosa flessibilità del diritto secondo le circostanze concrete e reali, piegandone l’applicazione troppo rigida, quella letterale appunto.
Il calcio che credeva grazie alla tecnologia di essere entrato nel futuro, se continuerà ad accettare un’applicazione letterale del protocollo VAR, senza alcun riferimento allo spirito del gioco, precipiterà in un’epoca culturalmente men che medievale.
Leggi tutte le puntate di Cultural Intelligence
Guglielmo De Feis è docente di Cultural Intelligence al Settore Tecnico di Coverciano (nei corsi Master Uefa Pro, Direttore Sportivo, Preparatori Atletici, Osservatori) e al Coni (al corso per Team Manager).
La Cultural Intelligence è la capacità di relazionarsi e lavorare efficacemente negli ambiti interculturali e multiculturali. Psicologia individuale, sociologia antropologica, comunicazione cross culturale e interculturale sono tutte discipline direttamente dipendenti dalla Cultural Intelligence (C.Q.).