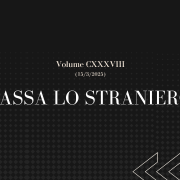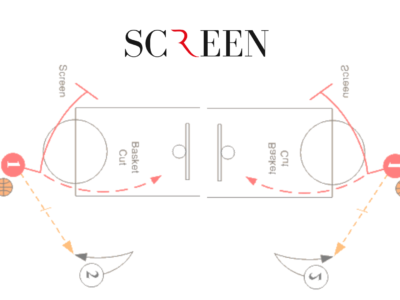di Guglielmo De Feis
Recentemente Fabio Capello, in un’intervista al quotidiano spagnolo El Mundo ha detto che “Guardiola ha rovinato il calcio, non per sua colpa, ma a causa dei suoi imitatori”. Naturalmente un’espressione tanto perentoria – quanto, forse, provocatoria – non poteva non suscitare reazioni in puro stile calcistico, ovvero una serie di dichiarazioni di appartenenza a un’identità culturale collettiva invece che opinioni derivanti da un ragionato pensiero individuale. Come al solito, in definitiva, la questione è stata ridotta banalmente a “giochismo” vs “risultatismo”.
Per apportare alla discussione un contributo – il più possibile costruttivo – si potrebbe precisare che Guardiola non ha rovinato il calcio, ma lo ha “hackerato”.
Il concetto di hacking* è indissolubilmente, ma erroneamente, collegato all’informatica e di conseguenza ad un’attività illegale – se non proprio truffaldina – per ottenere degli indebiti vantaggi.
L’hacking è in realtà – nel suo significato generico e più ampio – un’attività intrinsecamente umana consistente nell’affrontare un sistema complesso con senso critico e pensiero laterale per identificarne prima, e sfruttarne poi, le vulnerabilità in maniera da sovvertirne gli scopi iniziali.
In pratica Guardiola – come già prima di lui, Rinus Michels e il suo calcio totale negli anni settanta (col fuorigioco) e Arrigo Sacchi e il suo pressing asfissiante negli anni ottanta (col fallo tattico) – ha compreso che nelle maglie del regolamento e in quelle delle tattiche utilizzate dagli avversari, esisteva uno spazio attraverso il quale inserirsi, con la conseguente possibilità di costringere tutti ad adeguarsi a una differente e insolita maniera di giocare: quella del palleggio infinito, in avanti e indietro. Nel calcio non esiste, infatti, il limite di tempo per il possesso offensivo.
Michels, Sacchi e Guardiola certamente non sono tre autentici imbroglioni – perché non hanno esplicitamente violato alcuna regola – ma sono tre geniali innovatori che dopo aver individuato delle falle sistemiche hanno anche trovato il modo per trarne vantaggio.
Il ciclo vitale dell’hacking, oltretutto, spiega anche la seconda parte della frase di Fabio Capello, quella che indica negli imitatori di Guardiola i reali responsabili della rovina del calcio.
Quando l’hacker scopre la vulnerabilità del sistema e lo aggira, inventa un “exploit” tecnico che gli permette di sfruttarla. A quel punto vi è la reazione del sistema da parte di altri attori presenti. Vi sono molti imitatori, che provano a ripetere lo stesso exploit, e di conseguenza anche altri soggetti che sono, a quel punto, obbligati a difendersene. Ad esempio è impossibile non riconoscere che dall’esordio del tiki taka del Barcellona di Guardiola sono comparsi centinaia di epigoni determinati a giocare nello stesso modo. È altresì difficile non vedere nella partita giocata dall’Inter di Mourinho a Barcellona (la semifinale di ritorno della Champions 2010) un “controhack” al tiki taka, con la chiusura delle linee di passaggio invece del tentativo diretto di riconquista della palla.
A non aver colpevolmente risposto, fino ad oggi, è invece il sistema calcio nel suo insieme, indifferente alla deriva calcistica degli ultimi anni – quella cui si riferisce Capello quando parla della noia dei mille passaggi all’indietro – oppure incapace di prendere misure adeguate per arginarla.
Oggi le partite sono quasi sempre una sfida tra una squadra che tiene il pallone, per la maggior parte del tempo nella sua metà campo, ed una che se ne sta rintanata con tutti i suoi calciatori nella propria. Il pallone invece di essere conteso in duelli tra avversari in mezzo agli schieramenti delle due squadre è sempre e solo nella disponibilità totale di una delle due mentre l’altra gioca (si fa per dire) con tutti e dieci i suoi calciatori dietro la linea della palla e il più possibile vicino alla propria porta.
Che un sistema sia hackerato è dimostrato dal fatto che ciò che avviene nella realtà non sia quanto auspicassero gli inventori al momento della scelta delle regole per il corretto funzionamento del sistema stesso.
Il fuorigioco e il fallo tattico sono stati diverse volte nella storia del calcio corretti e sanzionati in maniera diversa. Nella ratio delle regole che prevedevano la sanzione per l’attaccante in fuorigioco, o quella per il calciatore che interrompeva il gioco con un fallo, non era ricompresa ovviamente la possibilità dell’uso ostruzionistico sia della tattica del fuorigioco sia quella del reiterato fallo volontario a metà campo.
Non era certamente immaginata come realistica – e nemmeno voluta peraltro – l’eventualità che tutti i calciatori di una squadra giocassero dietro la linea della palla e negli ultimi venti metri di campo. In quel caso infatti, la regola del fuorigioco sarebbe stata identica a quella del rugby (la linea del pallone) e con il conseguente obbligo del passaggio indietro al compagno che (solo da dietro) poteva quindi sopraggiungere.
Il calcio in questo momento sta subendo anche un secondo e ancor più grave atto di hackeraggio e questo, oltretutto, è deliberatamente truffaldino fin dalle intenzioni.
L’ingresso della tecnologia del VAR ha creato la possibilità di individuare il minimo contatto avvenuto in campo. La conseguenza di ciò è che esistono decine di hacker calcistici (sotto forma di simulatori) che hanno ormai perfettamente individuato la falla di sistema nella maniera di arbitrare (la misurabilità oggettiva di un contatto e l’incapacità di giudicarne l’importanza) e si comportano di conseguenza. Il risultato (terrificante) è quello di vedere oggi calciatori che cercano – invece di evitare – lo scontro con l’avversario per poi restare a terra fino all’obbligo di controllo tecnologico al VAR di quanto loro hanno artificiosamente creato.
Hanno individuato altre falle di sistema anche i difensori, accortisi che se il contatto coi piedi – definito negligente e imprudente – viene sempre punito, anche se accidentale e irrisorio, quello portato con le mani – sotto forma di spinta o trattenuta – viene tollerato anche se prolungato e voluto.
In questo momento il calcio sta vivendo due forme di hacking (quello tattico e quello giuridico) per una ragione semplice: non si sta dimostrando all’altezza di governare le due innovazioni tecnologiche degli ultimi anni (Match Analysis e VAR).
*Il termine “hack” ha origini etimologiche che risalgono al 1955, quando fu utilizzato per la prima volta nel Tech Model Railroad Club del MIT (Massachusetts Institute of Technology). In questo contesto, il termine indicava un approccio innovativo e ingegnoso alla risoluzione dei problemi, senza il significato illegale o antagonistico che avrebbe acquisito in seguito. Inizialmente, “hack” era sinonimo di un’abilità tecnica o creativa per affrontare sfide in modi non convenzionali. Negli anni Ottanta, il termine “hacking” cominciò a essere associato principalmente all’infrazione dei sistemi di sicurezza informatici. Da quel momento, non si riferiva più solo alla capacità di far fare a un sistema qualcosa di nuovo, ma anche alla possibilità di fargli fare qualcosa che non avrebbe dovuto fare.
Schneier, B. (2024). La mente dell’hacker: Trovare la falla per migliorare il sistema (P. Bassotti, Trad.). Luiss University Press. (Opera originale pubblicata nel 2023).
Leggi tutte le puntate di Cultural Intelligence
Guglielmo De Feis è docente di Cultural Intelligence al Settore Tecnico di Coverciano (nei corsi Master Uefa Pro, Direttore Sportivo, Preparatori Atletici, Osservatori) e al Coni (al corso per Team Manager).
La Cultural Intelligence è la capacità di relazionarsi e lavorare efficacemente negli ambiti interculturali e multiculturali. Psicologia individuale, sociologia antropologica, comunicazione cross culturale e interculturale sono tutte discipline direttamente dipendenti dalla Cultural Intelligence (C.Q.).