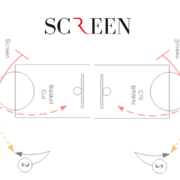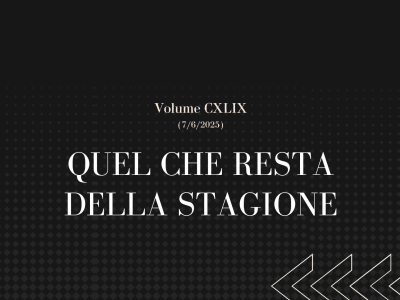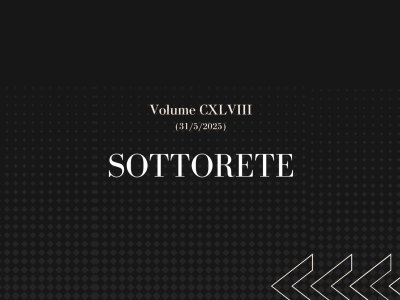Foto di copertina: abraham suazo from Pixabay
«Per me lo sport è una religione. Con un sentimento religioso»: è per primo Pierre de Coubertin, il padre dell’olimpismo moderno, a mettere nella stessa frase sport e religione. Due fenomeni sociali apparentemente lontani, ma che si sfiorano, si toccano e che a volte si mischiano. L’hanno fatto nel passato, nel presente e lo faranno probabilmente nel futuro, di sicuro lo fanno nelle parole di chi lo sport lo descrive, nella mistica dei tifosi e in tutta una serie di altre situazioni delle quali, magari, nemmeno ci rendiamo conto. Il rapporto tra le due sfere, però, non è sempre filato liscio: a volte collaterali, a volte irriducibili, sport e religione disegnano linee che a volte procedono parallele, altre si intersecano, altre tendono ad allontanarsi, ma è proprio per questo che vale la pena analizzarne alcuni aspetti.
Nel giorno del Signore Tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento il primo contatto tra sport e religione è uno scontro, soprattutto nel mondo anglosassone. Lì, dove lo sport moderno è stato inventato e dove è nato il concetto di tempo libero, la pratica sportiva, che si svolge per la massima parte la domenica, l’unico giorno libero della settimana va a cozzare contro l’interpretazione letterale della Bibbia soprattutto dei gruppi protestanti, luterani e anglicani. Cioè che la domenica è il giorno del Signore, in cui oltre a riposare, bisogna cantare le sue lodi e la sua gloria. Per questo non si gareggia. È la storia di tanti, in particolare di Eric Liddell, il magnifico velocista (e rugbista) la cui vicenda, peraltro molto rimaneggiata, ha ispirato Momenti di Gloria, o di Jonathan Edwards, figlio di un pastore che all’inizio della sua carriera non gareggiava la domenica e che ora, paradosso della ragione, si proclama ateo.