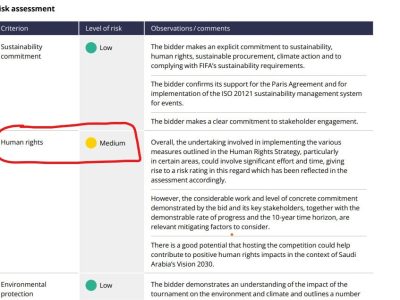di Ernesto Kieffer
Il giornalista inglese James Montague ha dedicato la sua vita professionale a studiare e raccontare il fenomeno degli ultras negli stadi di calcio. Un fenomeno controverso, spesso associato a violenza e intrighi con il malaffare (come di recente capitato proprio in Italia, con le connessioni emerse fra ’Ndrangheta e curve di Milan e Inter a San Siro). Andando, però, più a fondo della tematica si può scoprire che in realtà c’è anche qualcosa di più profondo. Esiste, ad esempio, un interessante sistema di valori (ma dovremmo forse chiamarli “controvalori”) che comunque regge l’intera comunità degli ultras in giro per il mondo, i quali, in determinate circostanze, hanno saputo dare un contributo importante, se non addirittura determinante, per l’ottenimento di determinati risultati: ci riferiamo alle rivoluzioni contro i dittatori o, più banalmente, all’aiuto che viene dato alle fasce più fragili della popolazione.
Di questo e molto altro ne abbiamo parlato con il giornalista inglese, nelle scorse settimane in tour in Italia (fra Genova, Milano, Verona e Rovereto) per presentare la sua ultima fatica, Fra gli ultras – Viaggio nel tifo estremo (edizioni 66thand2nd, collana Attese).
Come nasce l’interesse giornalistico per il fenomeno degli ultras?
«La mia ricerca è nata nel momento stesso in cui sono diventato un giornalista sportivo. Da quando, da ragazzino, sono andato per la prima volta a vedere allo stadio quella che poi sarebbe diventata la mia squadra del cuore, il West Ham United, ho subito capito che il punto di vista da cui volevo osservare il calcio non era la tribuna, ma dove c’era più rumore, dove c’era la vita più vibrante. Anche da giornalista, pur avendo sempre avuto la possibilità di accedere alla tribuna stampa e in generale ai luoghi migliori per poter assistere a una partita di calcio, ho sempre scelto di vedere la partita “da dietro la porta”, in mezzo ai supporter. Può sembrare sacrilego, lo so, ma per me la parte meno interessante del calcio sono proprio i giocatori e le loro storie, che se ci pensiamo alla fine sono quasi sempre un po’ tutte uguali. In genere si parla di giovani di grande talento che ce la fanno o non ce la fanno ad arrivare alla ribalta internazionale. Le storie vere, per me, sono invece quelle che provengono dagli spalti e da quella cultura che gira intorno al mondo del calcio».
Qual è la storia del tifo organizzato?
«Già la parola “tifo” ci suggerisce che stiamo parlando di una sorta di “virus”. Detto questo l’estetica e lo stile di moltissime tifoserie, dall’Indonesia agli Stati Uniti, ci riconduce comunque sempre all’Italia, dove nasce veramente la cultura ultras. A dire il vero, però, la vera storia del tifo organizzato nasce in origine in Sud America, con il Nacional di Montevideo in Uruguay. Il tifoso da quelle parti si chiama “incha” e la “inchada” è la tifoseria. Incha, in spagnolo, significa gonfiare e il termine arriva dal lavoro di Prudencio Miguel Reyes, il gonfiapalloni della squadra della capitale uruguayana negli anni ’10 e ’20 del XX secolo, appunto, il quale oltre a gonfiare i palloni viveva le vicende del suo Nacional in modo viscerale, tanto che a bordo campo si agitava, incitava i giocatori e impazziva letteralmente per la squadra. Questo in un contesto in cui andare allo stadio la domenica era ancora un’attività molto borghese, tanto che spesso si andava con il vestivo migliore. Ci si accorse, all’epoca, che l’atteggiamento di Reyes costituiva una sorta di vantaggio per la squadra in campo, che migliorava le sue prestazioni e questo atteggiamento è diventato così l’origine del virus, che è andato pian piano ad ampliarsi. È stato prima esportato alla vicina Argentina e poi al resto del mondo. Fra l’altro non è certo un caso se il Boca Juniors di Buenos Aires, forse la squadra più importante del Sud America, è stata fondata da emigranti genovesi. Anche in questo caso, si vede, la mano degli italiani…».
Nelle ultime settimane in Italia ha tenuto banco la notizia del malaffare nelle curve, soprattutto quelle di Inter e Milan, con lo sfruttamento dei biglietti, dei parcheggi, del merchandising. Un fenomeno però che è arcinoto in Sud America, con le Barras Bravas che detengono quel tipo di racket. Ci sono parallelismi fra quanto accade in Italia e in Sud America?
«C’è sempre un file rouge, un punto in comune, tra tutti gli ambienti ultras. Come questo connubio con il business non lecito, che gira da sempre attorno al calcio. È una delle tante contraddizioni di questo mondo. D’altronde gli ultras hanno tutti quanti l’idea che attorno al calcio girino svariati milioni di euro e che loro, che fanno parte di quello spettacolo, dovrebbero ricevere anche la loro “fetta di torta”».

Definire ultras è la domanda che dà il là a tutta la sua ricerca…
«È una missione molto complicata. In Inghilterra, ad esempio, molti pensano che hooligans e ultrassiano sinonimi, ma non è affatto così. L’idea comune di tutti gli ultras, al di là delle differenze politiche, culturali, sociali, è non tanto un’avversione diretta nei confronti della polizia, che comunque c’è, ma una volontà di vivere al di fuori delle regole, al di fuori dello Stato, al di fuori delle logiche repressive e limitanti. Lo si trova ovunque, da Istambul a Los Angeles. I tifosi del Besiktas, ad esempio, hanno come motto “Siamo contro tutto, anche contro noi stessi”. Un ribellismo che si va a riscontrare in ogni luogo, pur in forme diverse».
Ci sono però vari modi di interpretare il ruolo di capo-ultras…
«Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolik e capo curva della Lazio, aveva persino cercato di partecipare alla scalata dell’acquisto della Lazio insieme alla Camorra. Oltre a controllare la curva della Lazio controllava una gran fetta del traffico di droga della Capitale, cosa che l’ha portato alla sua fine (è stato ucciso a Roma nell’agosto del 2019, ndr). Dall’altra parte, agli antipodi, c’è il “Bocia”, una sorta di figura mitologica del tifo dell’Atalanta, bandito da quasi trent’anni dagli stadi. Mentre Piscitelli sosteneva che la parte interessante del calcio sono gli ultras, il Bocia considera la squadra, i suoi giocatori, l’allenatore, la base di tutta la sua passione. E poi nemmeno un euro di ciò che viene creato da tutto l’indotto dei tifosi dell’Atalanta esce dalla curva. Tutto viene reinvestito nelle attività del gruppo, attività che tentano di dare risposte anche alla società, con l’aiuto diretto a chi ha problemi di tossicodipendenza, come alcuni ragazzi della curva, o a chi ha subito danni dal terremoto e via dicendo. Nessun ultras dell’Atalanta, per il Bocia, si sarebbe potuto definire tale se non avesse conosciuto anche tutti i nomi dei giocatori delle giovanili nerazzurre, mentre Piscitelli ha detto più volte che molto spesso lui non conosceva nemmeno i nomi di chi scendeva il campo la domenica con la maglia biancazzurra. Due visioni completamente diverse».
Che cosa li tiene insieme? Come fanno ad essere due facce della stessa medaglia?
«Sono entrambi fuori dal sistema. Hanno evidentemente approcci diversi, anche se entrambi contemplano la violenza, pur con finalità diverse. Piscitelli era un fascista, che quando entrava in una stanza veniva salutato con il saluto romano. Dall’altra parte abbiamo il Bocia che non ha nessun tipo di affiliazione politica, almeno apparente, ma la cui parte importante era il senso del dovere verso la comunità. A metterli insieme è certamente il carisma. La sensazione è che queste due persone potessero unire attorno a sé grandi gruppi di persone, alimentando la loro passione».
È un caso se le tue indagini nel mondo del calcio, dopo pochi mesi, abbiano poi spesso avuto dei risvolti e degli sviluppi anche di carattere storico? Sei stato in Ucraina, in Egitto, in Israele a studiare le curve di quei Paesi e spesso da lì sono partite rivoluzioni o avvenimenti storici importanti…
«Il motivo per cui il fenomeno degli ultras e del calcio in generale si interseca con la Storia è perché non si può mai veramente separarlo dalla politica. E non solo in accezione negativa (con il tifo di estrema destra, l’intolleranza e il razzismo che spesso caratterizzano queste comunità) ma anche e soprattutto perché in generale si tratta di persone che hanno un forte coinvolgimento. Questo regala loro la capacità di diventare anche una forza rivoluzionaria. Sono abituati ad avere a che fare con la violenza, ad avere scontri con la polizia, a essere repressi e in situazioni in cui esplode una rivoluzione o un cambiamento repentino, gli ultras sono stati sempre in grado di dare un contributo importante. Gli ultras dell’Ah Alì, in Egitto, hanno “studiato” a Milano, hanno visto San Siro e hanno portato in patria lo stile ultras del Milan. Allo scoppio della rivoluzione contro Mubarak, nel 2011, sono diventati immediatamente una forza rivoluzionaria. Tant’è che oggi Al Sisi ha deciso di rendere illegale far parte di gruppi ultras. Sembra strano che un presidente di un Paese letteralmente a pezzi come l’Egitto come prima cosa si preoccupi di annientare i gruppi ultras. E invece, dal suo punto di vista, ha un senso, perché ne teme la forza rivoluzionaria. D’altronde ho visto con i miei occhi l’importanza delle curve nei contesti rivoluzionari: ero in piazza Tahrir al Cairo e ho visto quello che cosa hanno fatto gli ultras. I cori, le bandiere, le canzoni che il popolo egiziano cantava venivano tutte dalla cultura ultras. Potrei dire la stessa cosa di ciò che è accaduto anche in Turchia, in piazza Taksim, ma anche in Serbia o in Ucraina, in piazza Maidan. I gruppi pro-Europa e anti-Russia di Kiev si sono coalizzati con gli ultras della Dinamo e degli altri club in chiave nazionalistica. Quello che univa queste persone è sempre stato il concetto de “il nemico del mio nemico è mio amico”. Il famigerato battaglione Azov è costituito dal 70% da ultras ucraini proprio per quel carisma e quella capacità di unire e organizzare che viene dalla loro esperienza ultras. Gli altri combattenti del battaglione arrivano peraltro dalle curve croate o da altri stadi d’Europa. Allo stesso tempo anche le truppe pro-russe vengono da gruppi ultras, in qualche caso anti-capitalisti o anti-americanisti, che li porta a combattere contro le truppe ucraine».
Poi c’è il capitolo dedicato ai Balcani e alla loro guerra di trent’anni fa. Cosa ci puoi dire in merito?
«Anche la guerra dei Balcani è stata caratterizzata dalla presenza degli ultras, provenienti ad esempio dalla tifoseria della Stella Rossa di Belgrado. Arkan, diventato famoso come il più grande criminale di guerra dei Balcani, andava personalmente a selezionare i combattenti all’interno delle curve. L’idea di fondo è che in Serbia, così come in Croazia e nelle altre repubbliche dell’ex Jugoslavia, le curve degli ultras sono state il primo campo di battaglia di quella guerra. D’altronde quelle stesse curve erano l’unico posto dove, dopo la morte di Tito, fosse possibile far nascere e crescere il nazionalismo e lo spirito indipendentista. Ancora oggi fuori dagli stadi, in quelle zone, si trovano statue dedicate ai combattenti di quelle guerre, che venivano appunto quasi tutti da quegli ambienti».
Quali sono i lati positivi della cultura ultras?
«Come detto prima di tutto l’aspetto rivoluzionario, che non è necessariamente negativo, anzi. In certe situazioni, come in Egitto, la cultura ultras è stata fondamentale per provare a cambiare una situazione disperata. Ogni atto di un ultras nei confronti della propria squadra è sempre un atto politico con cui cerca di lottare contro il sistema, che siano messaggi di sinistra o di destra. Vivere da ultras rappresenta una sorta di partecipazione politica, forse caotica, ma senz’altro reale, tangibile e appassionata. Poi c’è una sorta di grande performance diffusa in tutto il mondo che va a coniugarsi, secondo determinate specificità locali e culturali, con degli aspetti comuni alla mentalità ultras, che porta tutto questo a essere una sorta di enorme, collettiva performance artistica».
In questo momento pensiamo che gli ultras siano un problema da risolvere, qualcosa di negativo. E invece…?
«E invece, se ci pensiamo, durante il periodo del Covid, quando gli ultras non potevano andare allo stadio, valore del calcio, in termini di diritti televisivi, è crollato. Sappiamo che ogni singola pubblicità che le pay TV trasmettono per pubblicizzare il prodotto calcio ha almeno un’immagine che riguarda gli ultras. I quali fanno parte del prodotto, che lo si voglia o meno».
Come ci si può orientare, allora, con questa contraddizione, cioè fra ciò che si vuole sradicare e che viene visto come una sorta di piaga sociale e il business, anche televisivo, che non può prescindere da questo tipo di fenomeno?
«A differenza degli hooligans, che si basavano sulla violenza cieca, senza senso, l’ultras è molto più di un teppista. Come detto vive di partecipazione politica e civile, di senso di comunità, che è un patrimonio che non va sprecato anzi, va preservato. L’idea del pugno duro, della repressione e anche della gentrificazione degli stadi, che sta trasformando il calcio da sport popolare a sport per classe ricca, ha reso ad esempio gli stadi inglesi molto diversi da quelli tedeschi, dove la proprietà dei club è partecipativa. I tifosi, in Germania, vengono coinvolti nelle scelte della società e questo è un modo per pensare anche al futuro della squadra e della sua comunità. Quelle attività ultras, come ad esempio quelle fatte dai tifosi dell’Atalanta, in Germania vengono istituzionalizzate e in qualche modo fatte proprie dallo stesso club, che le regola, inserendole in una qualche sorta di schema. Questa è una via intelligente per gestire il fenomeno. Il mondo ultras e le sue derivazioni locali sono aspetti, in questo senso, che vanno preservati. L’idea di prendere gli ultras, sradicarli dalle curve e trasformarle in qualcosa di profondamente diverso può portare a perdere l’identità culturale anche del territorio. Risolvere il problema degli ultras significa, per me, ripensare le strutture di potere che stanno all’interno del calcio. Mi riferisco alle proprietà, alle leghe e tutto quanto gira attorno al sistema, che deve tener conto di un valore sociale che ha il calcio e di quella che è la sensibilità del pubblico».
Ernesto Kieffer inizia nel 2000 a collaborare con alcuni periodici veronesi come “L’Altro Giornale”, “L’Adige”, “Verona Fedele” e, in tempi più recenti, “Verona In”. Per “Radio Popolare Verona” in passato ha curato rubriche di cinema, musica e sport, mentre per “Stella FM” si è dedicato per molti anni alle radiocronache sportive. Oggi collabora anche con DAZN. Dopo l’esperienza con “Il Nazionale”, per “Heraldo” oggi è caporedattore della sezione Politica&Attualità e Sport. È giornalista professionista ed è direttore responsabile della rivista annuale, dedicata alla letteratura di fantascienza, “Ultracorpi – Il Fantastico nelle Arti dello Spettacolo”.