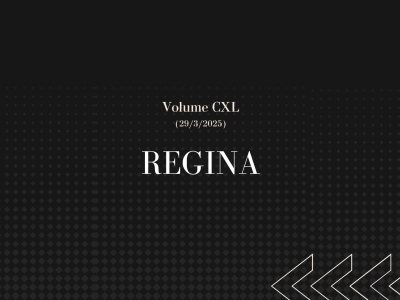C’è una retorica che si sgretola poco alla volta e, come sempre accade quando si attacca lo stereotipo, è un passo avanti, piccolo ma significativo. È quella che vorrebbe gli atleti, tutti giovani e belli come gli eroi, ma anche solidi, indistruttibili, disumani; baciati da talento e ricchezza, per questo lontani dalle fragilità esistenziali che, peraltro, anche per il semplice fatto di essere appunto ricchi e famosi, non dovrebbe avere cittadinanza nelle loro vite. Che, tuttavia, solo loro realmente conoscono, e allora ecco lo straniamento: Ashleigh Barty, numero 1 del tennis femminile, che si ritira a 25 anni, un’icona come Simone Biles atterrita dai twisties, dai suoi demoni, un’icona come Naomi Osaka che non fa più mistero di non poterne più e grida al mondo, dalla copertina del Time, che «it’s ok to not be ok» e sì, non è che si deve sempre rispondere che va tutto bene, quando non è vero.
È il tema della salute mentale, che già di suo porta con sé lo stigma della pazzia, figurarsi poi quando si parla di sport, laddove la debolezza è l’esatta antitesi di ciò che l’atleta è portato a rappresentare, almeno nell’immaginario collettivo e in ciò che gli viene richiesto. Lo stesso motto olimpico (citius, altius, fortius, prima che vi fosse aggiunto il termine communiter) evoca qualcosa “di più”, che certo è ciò a cui aspirano gli atleti, ma anche ciò che ci si attende da loro. Il punto è proprio qui, nelle aspettative, in ciò che gli altri vogliono che uno sia, e gli altri sono gli allenatori e i tecnici, alcune figure di famiglia, gli sponsor, i tifosi e gli appassionati, persino gli hater. In quest’ultimo caso entra poi in gioco anche il contesto di un’era come quella attuale nella quale lo sport d’élite è strettamente connesso a logiche di business in cui l’empatia non ha cittadinanza e oltretutto – cosa impossibile ancora meno di vent’anni fa �…